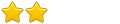abuso di autorità in presenza di militari riuniti per servizio
Cass. pen. Sez. I Sent., 14/01/2010, n. 4599
ABUSO DI AUTORITA’ MILITARE
REATO MILITARE
In tema di reati militari, è configurabile il reato di abuso di autorità di cui all’art. 196 c. p.m.p., nel caso in cui il superiore di grado abbia indirizzato agli inferiori espressioni idonee a ledere il loro prestigio e la loro dignità e sempre che l’offesa all’onore sia stata rivolta durante l’attività di servizio attivo, ricorrendo in caso contrario – ossia, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso al di fuori del servizio – l’operatività della clausola di esclusione del reato di ingiuria ad inferiore, prevista dall’art. 199 c. p.m.p. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 196 c. p.m.p., essendo l’ingiuria stata rivolta agli inferiori durante il periodo di addestramento ed alla presenza di altri militari in servizio).
Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per serv
Re: Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per serv
Ho trovato su internet questa notizia.
Se il militare si qualifica applicabile l’art. 189 e 196 c.p.m.p.
Un militare fuori servizio - in compagnia di alcune ragazze- tentava di entrare in una discoteca : al rifiuto del personale della vigilanza – dopo aver protestato violentemente – veniva richiamato all’ordine da un superiore, anch’esso fuori servizio, qualificatosi come ufficiale.
A fronte del richiamo del superiore, il militare fuori servizio, rispondeva con frasi gratuitamente offensive e scurrili.
Il seguito della vicenda vedeva, naturalmente, l’apertura di un procedimento disciplinare a carico del militare, al quale faceva seguito l’incriminazione presso la Procura Militare.
Infatti, sebbene l’ufficiale non avesse sporto querela, il fatto avvenuto al di fuori di un luogo militare, senza uniforme, per il solo fatto che il militare ( superiore in grado) si fosse qualificato, comporta l’applicazione del RDM e quindi, integralmente del codice penale militare.
L’assunto accusatorio, giova osservarlo, ha trovato indi l’avallo della Suprema Corte: pertanto anche ove le parti si invertissero – e fosse il superiore a minacciare / o ingiuriare l’inferiore al di fuori del servizio ( e qualificandosi) il subordinato, quest’ultimo potrà legittimamente presentare denuncia alla Procura Militare per il reato di cui all’art. 196 c.p.m.p.
Se il militare si qualifica applicabile l’art. 189 e 196 c.p.m.p.
Un militare fuori servizio - in compagnia di alcune ragazze- tentava di entrare in una discoteca : al rifiuto del personale della vigilanza – dopo aver protestato violentemente – veniva richiamato all’ordine da un superiore, anch’esso fuori servizio, qualificatosi come ufficiale.
A fronte del richiamo del superiore, il militare fuori servizio, rispondeva con frasi gratuitamente offensive e scurrili.
Il seguito della vicenda vedeva, naturalmente, l’apertura di un procedimento disciplinare a carico del militare, al quale faceva seguito l’incriminazione presso la Procura Militare.
Infatti, sebbene l’ufficiale non avesse sporto querela, il fatto avvenuto al di fuori di un luogo militare, senza uniforme, per il solo fatto che il militare ( superiore in grado) si fosse qualificato, comporta l’applicazione del RDM e quindi, integralmente del codice penale militare.
L’assunto accusatorio, giova osservarlo, ha trovato indi l’avallo della Suprema Corte: pertanto anche ove le parti si invertissero – e fosse il superiore a minacciare / o ingiuriare l’inferiore al di fuori del servizio ( e qualificandosi) il subordinato, quest’ultimo potrà legittimamente presentare denuncia alla Procura Militare per il reato di cui all’art. 196 c.p.m.p.
Re: Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per se
ABUSO DI AUTORITA' MILITARE - CASSAZIONE PENALE - REATO MILITARE
Cass. pen. Sez. I, (ud. 14-01-2010) 03-02-2010, n. 4599
Con sentenza 08/07/2009 la Corte Militare di Appello confermava la sentenza 04/07/2008 del G.U.P. del Tribunale Militare di Roma con la quale M.D. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare, perchè giudicato colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., e art. 196 c.p.m.p., comma 2, e art. 199 c.p.m.p., (fatti commessi in OMISSIS)
La Corte territoriale perveniva alla sua decisione rilevando che l'istruttoria dibattimentale aveva adeguatamente provato che l'imputato, maresciallo impegnato in qualità di istruttore di nuoto e di educazione fisica presso la scuola di fanteria di (OMISSIS), durante il periodo di addestramento ivi svolto, aveva indirizzato alle inferiori in grado, caporal maggiore C.M. e caporale Ma.So., "espressioni e comportamenti assolutamente idonei a ledere il loro prestigio e la loro dignità", espressioni e comportamenti analiticamente descritti nel capo di imputazione.
Confutando poi le doglianze prospettate dall'appellante, la Corte di merito rilevava, quanto alla possibile esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p., che i fatti avvennero mentre l'imputato era in servizio ed alla presenza di tutto il personale, che le parti offese ebbero a rendere testimonianze attendibili, confermate da testi presenti ( Mo. e V.), che il carattere offensivo delle frasi contestate e del gesto di calarsi i pantaloni e mostrare il di dietro era palese nell'in sè della condotta e per il senso letterale delle parole usate, in relazione, altresì, alla qualità delle persone offese, giovani donne all'inizio di una carriera militare, verso le quali frasi e comportamenti erano stati indirizzati.
Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità con quattro motivi di impugnazione.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente, col primo motivo di gravame, violazione dell'art. 199 c.p.m.p., sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di secondo grado: a) le condotte contestate al capo c) della rubrica si sono consumate cinque minuti dopo l'attività di addestramento ginnico - sportivo, quindi ormai al di fuori del servizio; b) nessun teste ha affermato che l'episodio era avvenuto alla presenza di altri militari, neppure indicati, peraltro, dalla parte offesa Ma..
Con il secondo motivo deduce che anche gli altri episodi, segnatamente quello del 29 novembre, in cui l'imputato affiancò l'autovettura ove si trovavano V. e C. per proferire la frase "quanto prendi?", ovvero l'altro, in cui alla Ma. venne detto "che occhi profondi che hai", sarebbero avvenuti al di fuori del servizio perchè ad addestramento ormai concluso.
Col terzo motivo di impugnazione censura la difesa ricorrente la sentenza di merito sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, giacchè le condotte contestate risultano consumate in un ambiente militare, ove non può distinguersi lo spirito militaresco tra militari donne e militari di sesso maschile, distinzione, viceversa, valorizzata dalla Corte di merito, che avrebbe altresì ghettizzato le posizioni delle due parti offese anche quando la condotta dell'imputato si rivolse a tutti i partecipanti all'addestramento, in particolare quando, in testa al gruppo e senza vedere chi fosse dietro di sè, ebbe a calarsi i pantaloni (di pochissimo, annota la difesa).
Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente il difetto di motivazione in ordine alla interpretazione data dai giudici di merito alla frase indirizzata dal M. alla C.: "quanto prendi?". Deduce sul punto il ricorrente che la frase non fu rivolta alla C., che, anzi, proprio dal prosieguo di battute si evince che la frase scherzosa era rivolta al V., il quale accompagnava la C., e che il V. fu indicato dal M. con la successiva frase "a quello con i capelli corti". Di qui il dedotto difetto di motivazione, in quanto era stata privilegiata la versione della parte offesa, la quale, proprio per tale qualità, andava valutata con pregnante e particolare motivazione, nello specifico omessa.
Insufficiente si appaleserebbe, altresì, la motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, in quanto il M. trattò le ragazze come parte integrante del gruppo, tenendo atteggiamenti solitamente tollerati negli ambienti militari, di guisa che non si può pervenire all'affermazione circa la sussistenza del dolo senza tener conto di ciò ed esclusivamente valutando "la natura stessa delle frasi adoperate".
La Corte di merito, inoltre, avrebbe del tutto ignorato le dichiarazioni del ten. P., favorevoli all'imputato, e la circostanza che le stesse parti offese non avrebbero indicato riscontri per confermare le loro affermazioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi di impugnazione costituiscono la pedissequa riproposizione delle doglianze di merito, puntualmente confutate dalla Corte territoriale con motivazione ampia, logica e giuridicamente corretta.
Ciò posto, giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui l'ulteriore principio di diritto affermato reiteratamente da questa Corte, secondo cui ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).
Palese, nel caso di specie, l'insistito tentativo difensivo di dare degli accadimenti di causa una versione diversa da quella motivatamente accreditata dai giudici territoriali, diversamente interpretando frasi, fatti, circostanze, si ribadisce, motivatamente valutati in chiave accusatoria dai giudici di primo e di secondo grado.
Nè possono ravvisarsi nel caso di specie gli estremi della esimente dedotta dal ricorrente, atteso che anche in relazione a tale punto la Corte di merito ha svolto una logica e puntuale motivazione, chiarendo da un lato che l'imputato commise i fatti mentre era impegnato nello specifico servizio di istruttore di nuoto e di educazione fisica in presenza di altri militari riuniti per
servizio (vedi in particolare l'episodio dell'abbassamento dei pantaloni e delle mutande), dall'altro che l'atteggiamento offensivo era diretto proprio nei confronti delle due ragazze, in quanto appartenenti all'altro sesso (vedi la frase rivolta alla C. "quanto vuoi" oppure le mani poste sulla schiena della Ma. mentre la stessa svolgeva un esercizio di stretching accompagnando tale frase con le parole "ehh, sii..., sii"). Al riguardo appare corretta l'interpretazione operata dai giudici di merito, in quanto la circostanza che da cinque minuti fosse terminata l'attività ginnica dell'addestramento e che gli attori della vicenda in esame fossero ormai intenti ad esaurire il loro impegno istituzionale, non esclude affatto che essi si trovassero a pieno titolo ad operare in costanza del servizio stesso. Infatti le condotte immediatamente successive all'attività di addestramento, quali il tornare verso gli spogliatoi, ovvero prepararsi semplicemente ad abbandonare la palestra o il campo di addestramento, ovvero il semplice portare sacche ed attrezzi verso la propria autovettura per fare ritorno a casa, integrano modalità dell'agire strettamente ed immediatamente collegati al servizio prestato, nei termini richiesti dall'art. 199 c.p.m.p., contenente la clausola di esclusione del reato.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000,00, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n.
186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010
Cass. pen. Sez. I, (ud. 14-01-2010) 03-02-2010, n. 4599
Con sentenza 08/07/2009 la Corte Militare di Appello confermava la sentenza 04/07/2008 del G.U.P. del Tribunale Militare di Roma con la quale M.D. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione militare, perchè giudicato colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., e art. 196 c.p.m.p., comma 2, e art. 199 c.p.m.p., (fatti commessi in OMISSIS)
La Corte territoriale perveniva alla sua decisione rilevando che l'istruttoria dibattimentale aveva adeguatamente provato che l'imputato, maresciallo impegnato in qualità di istruttore di nuoto e di educazione fisica presso la scuola di fanteria di (OMISSIS), durante il periodo di addestramento ivi svolto, aveva indirizzato alle inferiori in grado, caporal maggiore C.M. e caporale Ma.So., "espressioni e comportamenti assolutamente idonei a ledere il loro prestigio e la loro dignità", espressioni e comportamenti analiticamente descritti nel capo di imputazione.
Confutando poi le doglianze prospettate dall'appellante, la Corte di merito rilevava, quanto alla possibile esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p., che i fatti avvennero mentre l'imputato era in servizio ed alla presenza di tutto il personale, che le parti offese ebbero a rendere testimonianze attendibili, confermate da testi presenti ( Mo. e V.), che il carattere offensivo delle frasi contestate e del gesto di calarsi i pantaloni e mostrare il di dietro era palese nell'in sè della condotta e per il senso letterale delle parole usate, in relazione, altresì, alla qualità delle persone offese, giovani donne all'inizio di una carriera militare, verso le quali frasi e comportamenti erano stati indirizzati.
Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l'imputato, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità con quattro motivi di impugnazione.
Lamenta in particolare la difesa ricorrente, col primo motivo di gravame, violazione dell'art. 199 c.p.m.p., sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dal giudice di secondo grado: a) le condotte contestate al capo c) della rubrica si sono consumate cinque minuti dopo l'attività di addestramento ginnico - sportivo, quindi ormai al di fuori del servizio; b) nessun teste ha affermato che l'episodio era avvenuto alla presenza di altri militari, neppure indicati, peraltro, dalla parte offesa Ma..
Con il secondo motivo deduce che anche gli altri episodi, segnatamente quello del 29 novembre, in cui l'imputato affiancò l'autovettura ove si trovavano V. e C. per proferire la frase "quanto prendi?", ovvero l'altro, in cui alla Ma. venne detto "che occhi profondi che hai", sarebbero avvenuti al di fuori del servizio perchè ad addestramento ormai concluso.
Col terzo motivo di impugnazione censura la difesa ricorrente la sentenza di merito sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, giacchè le condotte contestate risultano consumate in un ambiente militare, ove non può distinguersi lo spirito militaresco tra militari donne e militari di sesso maschile, distinzione, viceversa, valorizzata dalla Corte di merito, che avrebbe altresì ghettizzato le posizioni delle due parti offese anche quando la condotta dell'imputato si rivolse a tutti i partecipanti all'addestramento, in particolare quando, in testa al gruppo e senza vedere chi fosse dietro di sè, ebbe a calarsi i pantaloni (di pochissimo, annota la difesa).
Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente il difetto di motivazione in ordine alla interpretazione data dai giudici di merito alla frase indirizzata dal M. alla C.: "quanto prendi?". Deduce sul punto il ricorrente che la frase non fu rivolta alla C., che, anzi, proprio dal prosieguo di battute si evince che la frase scherzosa era rivolta al V., il quale accompagnava la C., e che il V. fu indicato dal M. con la successiva frase "a quello con i capelli corti". Di qui il dedotto difetto di motivazione, in quanto era stata privilegiata la versione della parte offesa, la quale, proprio per tale qualità, andava valutata con pregnante e particolare motivazione, nello specifico omessa.
Insufficiente si appaleserebbe, altresì, la motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, in quanto il M. trattò le ragazze come parte integrante del gruppo, tenendo atteggiamenti solitamente tollerati negli ambienti militari, di guisa che non si può pervenire all'affermazione circa la sussistenza del dolo senza tener conto di ciò ed esclusivamente valutando "la natura stessa delle frasi adoperate".
La Corte di merito, inoltre, avrebbe del tutto ignorato le dichiarazioni del ten. P., favorevoli all'imputato, e la circostanza che le stesse parti offese non avrebbero indicato riscontri per confermare le loro affermazioni.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi di impugnazione costituiscono la pedissequa riproposizione delle doglianze di merito, puntualmente confutate dalla Corte territoriale con motivazione ampia, logica e giuridicamente corretta.
Ciò posto, giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui l'ulteriore principio di diritto affermato reiteratamente da questa Corte, secondo cui ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).
Palese, nel caso di specie, l'insistito tentativo difensivo di dare degli accadimenti di causa una versione diversa da quella motivatamente accreditata dai giudici territoriali, diversamente interpretando frasi, fatti, circostanze, si ribadisce, motivatamente valutati in chiave accusatoria dai giudici di primo e di secondo grado.
Nè possono ravvisarsi nel caso di specie gli estremi della esimente dedotta dal ricorrente, atteso che anche in relazione a tale punto la Corte di merito ha svolto una logica e puntuale motivazione, chiarendo da un lato che l'imputato commise i fatti mentre era impegnato nello specifico servizio di istruttore di nuoto e di educazione fisica in presenza di altri militari riuniti per
servizio (vedi in particolare l'episodio dell'abbassamento dei pantaloni e delle mutande), dall'altro che l'atteggiamento offensivo era diretto proprio nei confronti delle due ragazze, in quanto appartenenti all'altro sesso (vedi la frase rivolta alla C. "quanto vuoi" oppure le mani poste sulla schiena della Ma. mentre la stessa svolgeva un esercizio di stretching accompagnando tale frase con le parole "ehh, sii..., sii"). Al riguardo appare corretta l'interpretazione operata dai giudici di merito, in quanto la circostanza che da cinque minuti fosse terminata l'attività ginnica dell'addestramento e che gli attori della vicenda in esame fossero ormai intenti ad esaurire il loro impegno istituzionale, non esclude affatto che essi si trovassero a pieno titolo ad operare in costanza del servizio stesso. Infatti le condotte immediatamente successive all'attività di addestramento, quali il tornare verso gli spogliatoi, ovvero prepararsi semplicemente ad abbandonare la palestra o il campo di addestramento, ovvero il semplice portare sacche ed attrezzi verso la propria autovettura per fare ritorno a casa, integrano modalità dell'agire strettamente ed immediatamente collegati al servizio prestato, nei termini richiesti dall'art. 199 c.p.m.p., contenente la clausola di esclusione del reato.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.000,00, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n.
186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010
Re: Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per se
26/3/2009 - LA SENTENZA
Il capo utilizza un linguaggio volgare?
I suoi sottoposti possono denunciarlo
TURPILOQUIO.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ad introdurre una sorta di «teoria della relatività» del turpiloquio è la Cassazione che ha confermato la
condanna per ingiuria di un tenente.
ROMA
Il turpiloquio è offensivo solo se lo adopera il capo quando si rivolge ai «sottoposti». In pratica un linguaggio volgare, che tra due persone di «pari grado» (sociale o gerarchico) può essere considerato soltanto indice di cattiva educazione, diventa offensivo se adoperato dal capo o comunque da un superiore nei confronti di dipendenti o subordinati. Ad introdurre una sorta di «teoria della relatività» del turpiloquio è la Cassazione che ha confermato la condanna per ingiuria di un tenente colonnello dell’Aeronautica militare che «apostrofava» abitualmente i sottoposti con termini offensivi.
Nel respingere il ricorso dell’ufficiale, già condannato dal tribunale militare di Bari e dalla Corte d’appello di Napoli, i giudici della prima sezione penale della Corte hanno tuttavia sottolineato che «se può ammettersi che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando soltanto impoverimento del linguaggio e dell’educazione, le medesime espressioni rivolte ad un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina» riacquistano «il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante». La vicenda di cui si è occupata la Cassazione risale al periodo compreso tra l’autunno del 2002 e la fine del 2003. Il tenente colonnello, per un anno intero, non faceva mai mancare qualche offesa agli avieri: «testa di xxxxxxx», «non capisci un xxxxxxx» e una serie di «variazioni sul tema».
Dopo aver sopportato per un pò, i militari hanno presentato una denuncia collettiva. Il tenente colonnello si è difeso affermando di essere «stressato dall’adempimento di un dovere particolarmente forte, in circostanze talvolta drammatiche». Una giustificazione che non regge, a parere dei magistrati. E che anzi la Cassazione giudica «impertinente» perché è generica e senza alcun riferimento concreto. Da qui la decisione di confermare la condanna per ingiurie a 6 mesi e 20 giorni, ma con il beneficio della pena condonata. Insomma, il linguaggio da caserma può essere adoperato solo «rispettando» i gradi sulla divisa.
Il capo utilizza un linguaggio volgare?
I suoi sottoposti possono denunciarlo
TURPILOQUIO.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ad introdurre una sorta di «teoria della relatività» del turpiloquio è la Cassazione che ha confermato la
condanna per ingiuria di un tenente.
ROMA
Il turpiloquio è offensivo solo se lo adopera il capo quando si rivolge ai «sottoposti». In pratica un linguaggio volgare, che tra due persone di «pari grado» (sociale o gerarchico) può essere considerato soltanto indice di cattiva educazione, diventa offensivo se adoperato dal capo o comunque da un superiore nei confronti di dipendenti o subordinati. Ad introdurre una sorta di «teoria della relatività» del turpiloquio è la Cassazione che ha confermato la condanna per ingiuria di un tenente colonnello dell’Aeronautica militare che «apostrofava» abitualmente i sottoposti con termini offensivi.
Nel respingere il ricorso dell’ufficiale, già condannato dal tribunale militare di Bari e dalla Corte d’appello di Napoli, i giudici della prima sezione penale della Corte hanno tuttavia sottolineato che «se può ammettersi che nel linguaggio comune e tra pari molte delle espressioni volgari usate hanno perso la loro connotazione offensiva, denotando soltanto impoverimento del linguaggio e dell’educazione, le medesime espressioni rivolte ad un sottoposto, in violazione delle regole di disciplina» riacquistano «il loro specifico significato spregiativo e lesivo, penalmente rilevante». La vicenda di cui si è occupata la Cassazione risale al periodo compreso tra l’autunno del 2002 e la fine del 2003. Il tenente colonnello, per un anno intero, non faceva mai mancare qualche offesa agli avieri: «testa di xxxxxxx», «non capisci un xxxxxxx» e una serie di «variazioni sul tema».
Dopo aver sopportato per un pò, i militari hanno presentato una denuncia collettiva. Il tenente colonnello si è difeso affermando di essere «stressato dall’adempimento di un dovere particolarmente forte, in circostanze talvolta drammatiche». Una giustificazione che non regge, a parere dei magistrati. E che anzi la Cassazione giudica «impertinente» perché è generica e senza alcun riferimento concreto. Da qui la decisione di confermare la condanna per ingiurie a 6 mesi e 20 giorni, ma con il beneficio della pena condonata. Insomma, il linguaggio da caserma può essere adoperato solo «rispettando» i gradi sulla divisa.
Re: Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per se
Argomento diverso dal post ma pur sempre interessante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calci e pugni ad un uomo ammanettato.
Poliziotto condannato: "Violenza gratuita"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercoledì 10 Settembre 2014
ROMA - La Cassazione ha comunicato una decisione che sicuramente farà discutere.
«È 'in re ipsa' che prendere a calci un uomo ammanettato sia ben al di fuori dei compiti di istituto di un appartenente alle forze dell'ordine».
Questo uno dei passaggi delle motivazioni in base alle quali la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per Nicola R., il capo equipaggio di una volante di polizia che non aveva alzato un dito per impedire che fosse picchiato pesantemente dal suo collega di pattuglia un uomo già caricato sulla 'volante' e bloccato dalle manette dopo essere stato fermato perchè non sobrio.
Alla vittima, Enrico E., portato via a forza da un locale pubblico perchè aveva alzato troppo il gomito, erano state riscontrate tumefazioni e numerose fratture al Pronto soccorso dell'ospedale di Mantova, la provincia lombarda dove il fatto è avvenuto il due giugno del 2006.
Accortosi del pestaggio che stava avvenendo all'interno della 'volante', un appuntato della polizia giudiziaria di Brescia - che da una finestra aveva visto la scena di violenza gratuita - aveva richiamato gli agenti a comportarsi in modo «più consono al ruolo e al servizio svolto».
In risposta aveva ottenuto solo una brutta reazione verbale del capo equipaggio che lo aveva esortato a farsi i fatti suoi e a rientrare in casa.
L'appuntato bresciano, al processo per lesioni personali aggravate a carico di Nicola R. - l'altro agente è stato giudicato e condannato separatamente - ha reso la sua testimonianza che, insieme a quella della vittima e ai referti medici, ha portato alla condanna dell'imputato.
In primo grado, il Gup del Tribunale di Mantova il cinque febbraio 2009 aveva inflitto a Nicola R. due anni e due mesi di carcere, poi ridotti dalla Corte di Appello di Brescia, il 27 marzo 2013, a un anno e quattro mesi previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Il verdetto di secondo grado è stato confermato dalla Quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 37437 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi il sei giugno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calci e pugni ad un uomo ammanettato.
Poliziotto condannato: "Violenza gratuita"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercoledì 10 Settembre 2014
ROMA - La Cassazione ha comunicato una decisione che sicuramente farà discutere.
«È 'in re ipsa' che prendere a calci un uomo ammanettato sia ben al di fuori dei compiti di istituto di un appartenente alle forze dell'ordine».
Questo uno dei passaggi delle motivazioni in base alle quali la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per Nicola R., il capo equipaggio di una volante di polizia che non aveva alzato un dito per impedire che fosse picchiato pesantemente dal suo collega di pattuglia un uomo già caricato sulla 'volante' e bloccato dalle manette dopo essere stato fermato perchè non sobrio.
Alla vittima, Enrico E., portato via a forza da un locale pubblico perchè aveva alzato troppo il gomito, erano state riscontrate tumefazioni e numerose fratture al Pronto soccorso dell'ospedale di Mantova, la provincia lombarda dove il fatto è avvenuto il due giugno del 2006.
Accortosi del pestaggio che stava avvenendo all'interno della 'volante', un appuntato della polizia giudiziaria di Brescia - che da una finestra aveva visto la scena di violenza gratuita - aveva richiamato gli agenti a comportarsi in modo «più consono al ruolo e al servizio svolto».
In risposta aveva ottenuto solo una brutta reazione verbale del capo equipaggio che lo aveva esortato a farsi i fatti suoi e a rientrare in casa.
L'appuntato bresciano, al processo per lesioni personali aggravate a carico di Nicola R. - l'altro agente è stato giudicato e condannato separatamente - ha reso la sua testimonianza che, insieme a quella della vittima e ai referti medici, ha portato alla condanna dell'imputato.
In primo grado, il Gup del Tribunale di Mantova il cinque febbraio 2009 aveva inflitto a Nicola R. due anni e due mesi di carcere, poi ridotti dalla Corte di Appello di Brescia, il 27 marzo 2013, a un anno e quattro mesi previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Il verdetto di secondo grado è stato confermato dalla Quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 37437 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi il sei giugno.
Re: Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per se
gazzellascorte ha scritto:ci sono andati pesanti comunque con la pena
Io invece penso che i giudici siano stati anche fin troppo indulgenti e sarei curioso di conoscere la pena inflitta all' altro...vogliamo chiamarlo "poliziotto"?...fate voi.
Inoltre sarei anche curioso di sapere quali sono state le conseguenze di natura disciplinare, riguardanti slprattutto il "poliziotto pugile".
Punti di vista...
Re: Abuso di autorità in presenza di militari riuniti per se
ingiuria militare
---------------------------------------------------
SENTENZA N. 215
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, promossi dalla Corte militare d’appello di Roma con ordinanze del 18 febbraio, dell’11 e del 26 aprile 2016, iscritte ai nn. 91, 102 e 117 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 21 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visti l’atto di costituzione di F. P., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 26 settembre e nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi l’avvocato Valeria Bonfiglio per F. P. e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– La Corte militare d’appello di Roma, con tre distinte ordinanze di analogo tenore, pronunciate in altrettanti giudizi, rispettivamente del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016), dell’11 aprile 2016 (r.o. n. 102 del 2016) e del 26 aprile 2016 (r.o. n. 117 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato, le quali, se poste invece in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto di cui all’art. 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
1.1.– Nell’ordinanza del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016), il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in ordine all’appello presentato dall’imputato F. P., condannato in primo grado dal Tribunale militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione militare per il reato di ingiuria continuata e aggravata ai danni di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare (ai sensi degli artt. 226 e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace e dell’art. 81 del codice penale).
1.2.– Nell’ordinanza dell’11 aprile 2016 (r.o. n. 102 del 2016), il giudice a quo espone che l’imputato A. T. è stato condannato in primo grado per il reato di ingiuria pluriaggravata (ai sensi degli artt. 47, numeri 2 e 4, e 226 cod. pen. mil. pace) per aver rivolto una frase offensiva nei confronti di una caporal maggiore, mentre si trovavano entrambi all’interno della mensa unificata di una caserma di Milano. Riferisce il giudice a quo che essi condividevano lo stesso tavolo insieme ad altri militari; che durante la consumazione del pasto l’imputato aveva intrattenuto altri due militari presenti raccontando loro come aveva trascorso la serata precedente; e che, nel corso di tale racconto, egli aveva rivolto la frase offensiva nei confronti della caporal maggiore, fino a quel momento non coinvolta nella conversazione.
1.3.– Infine, la Corte militare d’appello, nell’ordinanza 26 aprile 2016 (r.o. n. 117 del 2016), riferisce di essere chiamata a decidere il ricorso in appello presentato da R. P., imputato di ingiuria aggravata (ai sensi degli artt. 226 e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace) e minaccia aggravata (ai sensi degli artt. 229 e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace).
In merito al primo capo d’imputazione, il rimettente ricorda che R. P., tenente colonnello, aveva rivolto una frase offensiva nei confronti di un maggiore in occasione di un acceso scambio di battute, mentre il primo si trovava nel cortile condominiale e la persona offesa era alla finestra del suo appartamento, e che la discussione tra i due sarebbe scaturita da questioni attinenti a rapporti di vicinato e di condivisione condominiale, sia pure relativa ad alloggi militari.
2.– In tutte le ordinanze, la Corte militare d’appello ricorda, anzitutto, che il d.lgs. n. 7 del 2016 ha abrogato, tra gli altri, il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 cod. pen. (art. 1); ha previsto che il medesimo fatto, se commesso dolosamente, costituisce un illecito civile, obbligando l’autore, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, al pagamento di una sanzione pecuniaria civile (art. 4); e ha stabilito che tali disposizioni si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo (art. 12).
Nelle ordinanze è premesso che tale decreto legislativo non ha ricompreso tra le norme da «depenalizzare» anche il reato militare di ingiuria previsto e punito dall’art. 226 cod. pen. mil. pace, e che l’effetto abrogativo non potrebbe essere desunto in via interpretativa, atteso il carattere tassativo dei reati elencati nel decreto, il fatto che spetta al legislatore scegliere quali reati «depenalizzare» e, infine, la necessità di assicurare certezza giuridica in tale materia.
Con riferimento a tutti e tre i casi sottoposti al suo giudizio, il giudice a quo sottolinea poi che si tratta di vicende riconducibili a contesti esclusivamente personali e privati, del tutto esulanti dalla sfera del servizio e della disciplina militare (come, in particolare, è dimostrato – in tutti i procedimenti – dall’esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 196 cod. pen. mil. pace, che prevede il reato di ingiuria ad un inferiore).
In tutti e tre i casi sarebbe, dunque, applicabile l’art. 226 cod. pen. mil. pace, che – in seguito alla ricordata «depenalizzazione» – prevede ora il reato «esclusivamente militare» di ingiuria (secondo la definizione contenuta all’art. 37, secondo comma, cod. pen. mil. pace, in base al quale «[è] reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune»).
Ritiene il rimettente che la «depenalizzazione» del reato di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen. avrebbe determinato un’irragionevole dilatazione della nozione di reato militare, in quanto vi rientrerebbero anche fatti potenzialmente estranei alla tutela degli interessi militari (difettando, per il reato di ingiuria, una norma analoga all’art. 199 cod. pen. mil. pace, che esclude la configurabilità di alcuni reati, se commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare). L’intervento legislativo avrebbe, inoltre, determinato un’irragionevole diversità di trattamento tra militari imputati di ingiuria e soggetti non appartenenti alle Forze armate, in quanto ai primi si applicherebbe ancora la sanzione penale, mentre ai secondi quella civile.
A tale conclusione non osterebbe – secondo il rimettente – la sentenza n. 186 del 2001, nella quale la Corte costituzionale avrebbe sottolineato come la lamentata diversità di trattamento troverebbe giustificazione nella peculiare posizione del cittadino inserito nell’ordinamento militare, poiché in quella occasione – sempre nella lettura della Corte militare d’appello – tale affermazione avrebbe riguardato una diversa ipotesi, ossia l’impossibilità di subordinare ad un interesse privato il perseguimento di reati in cui è insita un’offesa alla disciplina e al servizio (ciò, in particolare, si desumerebbe dalle precisazioni contenute nella successiva sentenza della Corte costituzionale n. 273 del 2009).
In ogni caso, sottolineano le ordinanze di rimessione, mentre la questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza n. 186 del 2001 aveva ad oggetto due differenti modalità di promovimento dell’azione penale, quella ora all’esame della Corte costituzionale pone a raffronto due fattispecie, punite l’una con la sanzione penale e l’altra con quella civile.
È, inoltre, ancora menzionata la sentenza n. 273 del 2009, nella quale la Corte costituzionale avrebbe affermato che la diffamazione militare (punita all’art. 227 cod. pen. mil. pace) e quella comune (di cui all’art. 595 cod. pen.) si distinguono esclusivamente per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa, che, per l’integrazione della prima fattispecie, devono essere entrambi militari. Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi – secondo il giudice a quo – per il reato di ingiuria.
Ad avviso del rimettente un diverso esito risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che avrebbe escluso che le esigenze della struttura militare possano essere considerate superiori agli altri beni costituzionalmente e ordinariamente tutelati (sono citate le sentenze n. 445 del 2002, n. 332 del 2000, n. 449 del 1999, n. 78 del 1989 e n. 278 del 1987).
Da ultimo, la Corte militare d’appello sottolinea come la formulazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace non consenta di individuare una connotazione di «militarità» della condotta che non sia la mera qualità di militari dei soggetti coinvolti: nessun altro elemento, cioè, consentirebbe al giudice militare di distinguere, nell’ambito della generale previsione contenuta nell’art. 226 cod. pen. mil. pace, un’ingiuria attinente a interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militare, o in generale ad interessi militari, rispetto ad un’ingiuria che tale connotazione non abbia. D’altro canto, sarebbe la previsione stessa dell’art. 199 cod. pen. mil. pace, in tema di non attinenza al servizio e alla disciplina militare, ad implicare l’impossibilità di connotare il reato previsto dall’art. 226 cod. pen. mil. pace come reato esclusivamente militare.
Pur dovendosi riconoscere, aggiunge il rimettente, che almeno per una parte delle condotte sussumibili nella previsione di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace sia ravvisabile «una, anche lata, correlazione con gli interessi, l’attività e l’ordinato andamento delle Forze Armate», che può giustificare la scelta del legislatore di mantenere una tutela di carattere penale, il vizio di legittimità costituzionale lamentato sarebbe, invece, palese per le ipotesi in cui nessun profilo di differenziazione con la norma penale comune sia riscontrabile e, dunque, «limitatamente alle fattispecie non connotate da alcun interesse militare».
3.– Con atti di identico tenore, rispettivamente depositati il 31 maggio 2016, il 14 giugno 2016 e il 5 luglio 2016, è intervenuto in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
Eccepisce preliminarmente la difesa statale, in relazione a tutti i giudizi, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza dovuta alla carente descrizione della fattispecie concreta, essendo solo genericamente richiamate, nel corpo del provvedimento, alcune delle modalità del fatto contestato.
Quanto al merito delle censure, l’Avvocatura generale dello Stato osserva, anzitutto, che la selezione dei reati da «depenalizzare» costituisce una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore, sottratta al sindacato della Corte costituzionale, salvo il limite della ragionevolezza.
Nei casi sottoposti al giudizio della Corte costituzionale, non vi sarebbe comunque – ad avviso della difesa statale – alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati.
Dopo aver ricostruito il contenuto degli artt. 196, 199 e 226 cod. pen. mil. pace e il rapporto tra tali disposizioni, l’Avvocatura generale dello Stato si sofferma, in particolare, sul significato del reato previsto dall’art. 196 cod. pen. mil. pace (minaccia o ingiuria a un inferiore). Essa afferma che, senza dubbio, è tale previsione a rispondere all’esigenza di tutelare l’irrinunciabile bene della disciplina militare, strettamente connaturata al rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra il soggetto appartenente ad un grado superiore e quello appartenente ad un grado inferiore (il quale implica l’osservanza, da parte del primo, dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione). Ma segnala come sia, tuttavia, possibile, «in sintonia con gli orientamenti della Consulta», enucleare «un concetto di disciplina militare più ampio, inclusivo certamente dell’aspetto gerarchico, ma sussistente anche in assenza di esso». Sarebbe proprio la disposizione censurata, l’art. 226 cod. pen. mil. pace, a completare, dunque, la tutela della disciplina militare, intesa quale coesa e ordinata convivenza nell’ambito del consorzio militare. La stessa Corte costituzionale avrebbe, del resto, individuato quali interessi connaturati al concetto di disciplina quelli di efficienza e coesione delle Forze armate (è citata la sentenza n. 298 del 1995).
Non sarebbe pertanto irragionevole la scelta del legislatore di mantenere una più intensa risposta punitiva per un identico fatto materiale che risulti commesso – sebbene per ragioni estranee al servizio – in un contesto, quello militare, ove l’ordinata convivenza è posta a fondamento dell’efficienza stessa delle Forze armate.
Osserva, quindi, l’Avvocatura generale dello Stato che – diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze di rimessione – non vi sarebbe alcuna «regressione della garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari di fronte alle esigenze della struttura militare», in quanto l’ordinamento militare non si presenta «come un aliud o contrario», bensì come un regime basato su deroghe puntuali rispetto al modello dell’amministrazione civile. La diversità di trattamento tra militari e altri cittadini non fonderebbe le proprie ragioni sulla tutela di beni superiori, ma di beni diversi.
Il differente regime sanzionatorio lamentato dal rimettente nelle ordinanze di rimessione troverebbe, dunque, la propria ragione d’essere nel fatto che l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 e l’art. 226 cod. pen. mil. pace apprestano la loro tutela ad interessi solo apparentemente uguali.
4.– Nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n. 91 del 2016, si è costituito innanzi alla Corte costituzionale, con atto depositato il 30 maggio 2016, F. P., parte del giudizio a quo, chiedendo che siano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte militare d’appello e che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace.
Considerato in diritto
1.– Con tre ordinanze di analogo tenore la Corte militare d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato.
È osservato nelle ordinanze di rimessione che tali condotte, se poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto di cui all’art. 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
Tale decreto ha, infatti, abrogato il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 del codice penale e ha previsto che il medesimo fatto, se commesso dolosamente, costituisce un illecito civile e che il responsabile è condannato, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, al pagamento di una sanzione pecuniaria civile.
Ad avviso del rimettente, l’abrogazione dell’art. 594 cod. pen. avrebbe determinato un’irragionevole dilatazione del reato militare di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, in quanto tale disposizione consente di punire penalmente anche fatti che – pur commessi da militari nei confronti di altri militari – si rivelano estranei alla tutela degli interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militari. Ciò produrrebbe un’ingiustificata diversità di trattamento tra militari imputati di ingiuria e soggetti non appartenenti alle Forze armate, in quanto ai primi si applicherebbe ancora la sanzione penale, mentre ai secondi quella civile.
Oltre al contrasto con l’art. 3 Cost., è lamentata la lesione dell’art. 52 Cost., in quanto, punendo con la sanzione militare anche condotte tenute in un contesto personale e privato, le esigenze della struttura militare finirebbero per porsi in una posizione di superiorità rispetto ad altri beni costituzionalmente ed ordinariamente tutelati.
2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con riferimento agli stessi parametri, sotto gli stessi profili e con le stesse argomentazioni. Ponendo, pertanto, identiche questioni, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia.
3.– In tutti i giudizi l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, assumendo che le ordinanze di rimessione non avrebbero adeguatamente illustrato le fattispecie sottoposte a giudizio. Ciò determinerebbe un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, preclusivo dell’esame del merito.
Tale eccezione deve essere respinta.
Va, in primo luogo, considerato che i giudici di primo grado hanno già qualificato in sentenza i fatti come astrattamente riconducibili al reato militare di ingiuria previsto dall’art. 226 cod. pen. mil. pace e che i rimettenti – in qualità di giudici d’appello – espressamente affermano di condividere tale qualificazione.
Quanto alla circostanza che le affermazioni asseritamente ingiuriose risultino non collegate al servizio e alla disciplina militare, per il momento e il luogo in cui sono pronunciate, essa emerge (per i giudizi di cui alle ordinanze r.o. nn. 102 e 117 del 2016) da una (pur essenziale) descrizione dei fatti di causa, ricavabile da entrambi i provvedimenti ricordati.
Vero che parca di informazioni sulla fattispecie di cui è giudizio risulta l’ordinanza r.o. n. 91 del 2016. Ma dalla motivazione di quest’ultima si evince che la vicenda all’esame del giudice d’appello attiene a più episodi di ingiuria militare, contestati nella forma del reato continuato, e che i giudici di prime cure hanno ritenuto di inquadrarla nella fattispecie di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, giacché, pur essendo l’imputato e la persona offesa militari rivestiti di grado diverso, la palese assenza di motivi attinenti al servizio e alla disciplina impediva di ipotizzare la distinta fattispecie di “ingiuria ad inferiore” ex art. 196 cod. pen. mil. pace. La circostanza che la stessa Corte d’appello affermi di condividere tale valutazione chiarisce come, anche nel giudizio di quest’ultima, le frasi offensive non presentino alcun collegamento con il servizio e la disciplina militare, così confermandosi l’applicabilità dell’art. 226 cod. pen. mil. pace e la rilevanza delle questioni sollevate.
4.– Reato «contro la persona» (così il Capo III del Titolo IV del codice penale militare di pace, nel quale è collocato), l’art. 226 punisce con la reclusione militare (fino a quattro mesi, ovvero fino a sei mesi se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato) il militare che offende l’onore o il decoro di altro militare presente, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, in particolare (per quel che rileva nelle fattispecie dei giudizi a quibus) il reato di ingiuria a un inferiore (art. 196 cod. pen. mil. pace).
Per comune consenso, consolidato attraverso la costante giurisprudenza di legittimità, l’area di applicazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace riguarda, anzitutto, i casi nei quali l’ingiuria, scambiata tra militari di grado diverso, avvenga per cause e in circostanze estranee al servizio e alla disciplina militare, come definite dall’art. 199 cod. pen. mil. pace. Il limite negativo di applicazione delle fattispecie dei più gravi reati di insubordinazione con ingiuria (art. 189 cod. pen. mil. pace) e di ingiuria a un inferiore (art. 196 cod. pen. mil. pace) si ricava appunto dall’art. 199 cod. pen. mil. pace (nel testo novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689, recante «Modifiche al codice penale militare di pace», quale risulta anche a seguito del parziale intervento ablativo di questa Corte, operato con sentenza n. 22 del 1991), il quale stabilisce (per la parte qui rilevante) che le norme relative (tra gli altri) ai reati di insubordinazione con ingiuria e di ingiuria ad un inferiore non si applicano quando alcuno dei fatti da esse previsti è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare e di un aeromobile militare.
In sostanza, i fatti di ingiuria commessi tra militari di grado diverso non integrano i reati di cui agli artt. 189 e 196 cod. pen. mil. pace allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare, ponendosi con questi in un rapporto di mera occasionalità. E, appunto, tali fatti, non essendo qualificabili come offensivi dello specifico interesse della disciplina militare, sono invece riconducibili al meno grave reato di ingiuria di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, che è (innanzitutto) reato contro la persona.
L’art. 226 cod. pen. mil. pace copre anche, ovviamente, i fatti d’ingiuria commessi tra militari di pari grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare, ma – si osservi – è altresì applicabile a quelli, sempre commessi tra militari di pari grado, che del bene della disciplina militare risultino invece offensivi, perché collegati a cause non estranee al servizio e alla disciplina come indicate all’art. 199 cod. pen. mil. pace. Il che induce a sottolineare che il reato di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, reato innanzitutto contro la persona, non è estraneo all’area degli interessi ricollegabili al bene della disciplina militare.
5.– Ciò premesso, le questioni non sono fondate, con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati.
5.1.– Le ordinanze di rimessione, come si è detto, non chiedono la caducazione dell’intero art. 226 cod. pen. mil. pace. Sul presupposto, appena chiarito, che la disposizione censurata punisce l’ingiuria tra militari di grado diverso se non c’è attinenza tra fatti ingiuriosi e disciplina e servizio militare, esse domandano, invece, una pronuncia che ne dichiari l’illegittimità costituzionale nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare, o comunque non afferenti ad interessi delle Forze armate. E non ci si può esimere dal rilevare, incidentalmente, che la manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momento, giacché obbligherebbe questa Corte a circoscrivere l’area di applicazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace attraverso formule uguali o analoghe a quella contenuta nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, così scegliendo, tra quelle in astratto ipotizzabili, una delle molte soluzioni – nella disponibilità del legislatore – per selezionare interessi non più meritevoli di tutela penale.
In ogni caso, sottolineano i rimettenti che le condotte ingiuriose tuttora penalmente rilevanti per i militari, se poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto dell’abrogazione dell’art. 594 cod. pen. (art. 1, lettera c, del d.lgs. n. 7 del 2016) e della sua sostituzione, con efficacia anche retroattiva (art. 12 del citato d.lgs.), con il nuovo istituto della sanzione pecuniaria civile, esplicitamente applicabile anche a colui che offende l’onore o il decoro di una persona presente (art. 4 del medesimo d.lgs.).
La lesione all’art. 3 Cost., secondo le ordinanze di rimessione, consisterebbe perciò nell’irragionevole disparità di trattamento derivante dalla mancata estensione all’art. 226 cod. pen. mil. pace (nella parte appena precisata) della medesima sorte cui il legislatore ha scelto di sottoporre il “parallelo” reato di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen.
Quella all’art. 52 Cost. (considerando la giurisprudenza di questa Corte richiamata, si intuisce trattarsi del terzo comma di tale articolo, pur non esplicitamente citato né nelle motivazioni né nei dispositivi delle ordinanze) sarebbe dovuta alla prevalenza delle esigenze dell’ordinamento militare (che dovrebbe essere informato allo spirito democratico della Repubblica) insita in una previsione che stabilisce l’irrogazione della pena della reclusione militare anche a fronte di condotte tenute in contesti che con l’area degli interessi militari paiono privi di connessioni.
5.2.– Invero, e innanzitutto, la mancata ricomprensione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace nell’ambito della abrogazione di reati che ha coinvolto l’art. 594 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 rientra sicuramente tra le scelte che il legislatore può compiere discrezionalmente, incontrando il limite della manifesta irragionevolezza.
Questa Corte ha stabilito che spetta al Parlamento una funzione centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare (ex multis, sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 364 del 2004; ordinanza n. 212 del 2004). Un tale principio risulta, a maggior ragione, applicabile anche al caso ora in esame, nel quale, in realtà, la scelta di politica criminale compiuta non ha determinato la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, ma – per la prima volta, e con innovazione ben più radicale – ha trasferito determinate condotte dal campo del diritto penale, e delle relative sanzioni, a quello del diritto civile, attraverso la previsione di illeciti, i quali, se commessi con dolo, obbligano l’autore, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 7 del 2016.
5.3.– È vero, come osservano i rimettenti, che a seguito della trasformazione dell’ingiuria “comune” da illecito penale a illecito civile, l’ingiuria “militare” ex art. 226 cod. pen. mil. pace è divenuto reato esclusivamente militare, ai sensi dell’art. 37 cod. pen. mil. pace. Non può essere, tuttavia, considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell’area del penalmente rilevante l’ingiuria tra militari, quand’anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina e il servizio militare, come definito dall’art. 199 cod. pen. mil. pace. Ciò sia perché, in termini generali, ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze (ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000), sia soprattutto perché, con riferimento particolare alla censura sollevata dai rimettenti, non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all’onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, continuando così ad assistere con sanzioni penali le eventuali infrazioni a tali regole.
È vero che le fattispecie di reato di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace e all’abrogato art. 594 cod. pen. si distinguono solo per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa (oltre che per tipologia ed entità della sanzione), tuttavia – a differenza di altre fattispecie oggetto di scrutinio da parte di questa Corte (sentenze n. 286 del 2008, n. 272 del 1997, n. 448 del 1991, n. 4 del 1974) – è proprio la qualifica militare di entrambi i soggetti (colui che offende e colui che subisce l’offesa) a rilevare per l’individuazione dei beni giuridici protetti dall’art. 226 cod. pen. mil. pace. Continuare a punire penalmente l’ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse.
Peraltro, come mostrano anche le fattispecie per cui è giudizio nei processi a quibus, la civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata coesione delle Forze armate. Considerazioni di fatto, ma non del tutto indifferenti ai fini dell’esito di questo giudizio di legittimità costituzionale, costringono inoltre a rilevare sia il permanere di episodi di “nonnismo”, pur dopo l’eliminazione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare.
Proprio da questo punto di vista, è importante osservare come i reati per i quali è stabilita la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi – fra i quali l’ingiuria di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace – sono puniti non a querela, bensì su richiesta del comandante di corpo, sulla base di quanto disposto dall’art. 260 dello stesso codice.
La ratio di tale disposizione, ha più volte osservato questa Corte, risiede nella opportunità di attribuire al comandante di corpo una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare e il ricorso all’ordinaria azione penale, sul presupposto che vi siano casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l’esercizio incondizionato dell’azione penale può causare al decoro dell’istituzione militare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso (sentenze n. 449 del 1991, n. 114 del 1982, n. 189 del 1976, n. 42 del 1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 e n. 410 del 2000, n. 396 del 1996).
Si deve, ora, aggiungere che l’eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, determinando l’assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica e “privata” dei contendenti, avrebbe tra i suoi non trascurabili effetti anche quello di impedire al comandante di corpo di chiedere il procedimento penale, a tutela di una vittima (dell’ingiuria) inserita in un contesto caratterizzato da rapporti di natura gerarchica. Un accoglimento, si osservi, che potrebbe persino provocare l’effetto di privare il suddetto comandante dell’opportunità di avere contezza dei fatti accaduti, presupposto per avviare almeno la (in quell’ipotesi residua) azione disciplinare.
5.4.– Quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’art. 52 Cost. (e in particolare del suo terzo comma, come s’è detto), è sufficiente osservare che il mantenimento dell’ingiuria tra militari nell’area del penalmente rilevante, pur quando commessa per cause estranee al servizio o alla disciplina militare, trova ragionevole fondamento nelle, appena ricordate, basilari esigenze di coesione dei corpi militari. Sotto questo profilo, tale soluzione non trasmoda in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l’ordinamento delle Forze armate (sentenza n. 45 del 1992 e ordinanza n. 322 del 2013).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, dalla Corte militare d’appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.
---------------------------------------------------
SENTENZA N. 215
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, promossi dalla Corte militare d’appello di Roma con ordinanze del 18 febbraio, dell’11 e del 26 aprile 2016, iscritte ai nn. 91, 102 e 117 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 21 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visti l’atto di costituzione di F. P., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 26 settembre e nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi l’avvocato Valeria Bonfiglio per F. P. e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– La Corte militare d’appello di Roma, con tre distinte ordinanze di analogo tenore, pronunciate in altrettanti giudizi, rispettivamente del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016), dell’11 aprile 2016 (r.o. n. 102 del 2016) e del 26 aprile 2016 (r.o. n. 117 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato, le quali, se poste invece in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto di cui all’art. 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
1.1.– Nell’ordinanza del 18 febbraio 2016 (r.o. n. 91 del 2016), il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in ordine all’appello presentato dall’imputato F. P., condannato in primo grado dal Tribunale militare di Roma alla pena di mesi tre di reclusione militare per il reato di ingiuria continuata e aggravata ai danni di un militare subordinato, commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare (ai sensi degli artt. 226 e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace e dell’art. 81 del codice penale).
1.2.– Nell’ordinanza dell’11 aprile 2016 (r.o. n. 102 del 2016), il giudice a quo espone che l’imputato A. T. è stato condannato in primo grado per il reato di ingiuria pluriaggravata (ai sensi degli artt. 47, numeri 2 e 4, e 226 cod. pen. mil. pace) per aver rivolto una frase offensiva nei confronti di una caporal maggiore, mentre si trovavano entrambi all’interno della mensa unificata di una caserma di Milano. Riferisce il giudice a quo che essi condividevano lo stesso tavolo insieme ad altri militari; che durante la consumazione del pasto l’imputato aveva intrattenuto altri due militari presenti raccontando loro come aveva trascorso la serata precedente; e che, nel corso di tale racconto, egli aveva rivolto la frase offensiva nei confronti della caporal maggiore, fino a quel momento non coinvolta nella conversazione.
1.3.– Infine, la Corte militare d’appello, nell’ordinanza 26 aprile 2016 (r.o. n. 117 del 2016), riferisce di essere chiamata a decidere il ricorso in appello presentato da R. P., imputato di ingiuria aggravata (ai sensi degli artt. 226 e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace) e minaccia aggravata (ai sensi degli artt. 229 e 47, numero 2, cod. pen. mil. pace).
In merito al primo capo d’imputazione, il rimettente ricorda che R. P., tenente colonnello, aveva rivolto una frase offensiva nei confronti di un maggiore in occasione di un acceso scambio di battute, mentre il primo si trovava nel cortile condominiale e la persona offesa era alla finestra del suo appartamento, e che la discussione tra i due sarebbe scaturita da questioni attinenti a rapporti di vicinato e di condivisione condominiale, sia pure relativa ad alloggi militari.
2.– In tutte le ordinanze, la Corte militare d’appello ricorda, anzitutto, che il d.lgs. n. 7 del 2016 ha abrogato, tra gli altri, il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 cod. pen. (art. 1); ha previsto che il medesimo fatto, se commesso dolosamente, costituisce un illecito civile, obbligando l’autore, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, al pagamento di una sanzione pecuniaria civile (art. 4); e ha stabilito che tali disposizioni si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo (art. 12).
Nelle ordinanze è premesso che tale decreto legislativo non ha ricompreso tra le norme da «depenalizzare» anche il reato militare di ingiuria previsto e punito dall’art. 226 cod. pen. mil. pace, e che l’effetto abrogativo non potrebbe essere desunto in via interpretativa, atteso il carattere tassativo dei reati elencati nel decreto, il fatto che spetta al legislatore scegliere quali reati «depenalizzare» e, infine, la necessità di assicurare certezza giuridica in tale materia.
Con riferimento a tutti e tre i casi sottoposti al suo giudizio, il giudice a quo sottolinea poi che si tratta di vicende riconducibili a contesti esclusivamente personali e privati, del tutto esulanti dalla sfera del servizio e della disciplina militare (come, in particolare, è dimostrato – in tutti i procedimenti – dall’esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 196 cod. pen. mil. pace, che prevede il reato di ingiuria ad un inferiore).
In tutti e tre i casi sarebbe, dunque, applicabile l’art. 226 cod. pen. mil. pace, che – in seguito alla ricordata «depenalizzazione» – prevede ora il reato «esclusivamente militare» di ingiuria (secondo la definizione contenuta all’art. 37, secondo comma, cod. pen. mil. pace, in base al quale «[è] reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune»).
Ritiene il rimettente che la «depenalizzazione» del reato di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen. avrebbe determinato un’irragionevole dilatazione della nozione di reato militare, in quanto vi rientrerebbero anche fatti potenzialmente estranei alla tutela degli interessi militari (difettando, per il reato di ingiuria, una norma analoga all’art. 199 cod. pen. mil. pace, che esclude la configurabilità di alcuni reati, se commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare). L’intervento legislativo avrebbe, inoltre, determinato un’irragionevole diversità di trattamento tra militari imputati di ingiuria e soggetti non appartenenti alle Forze armate, in quanto ai primi si applicherebbe ancora la sanzione penale, mentre ai secondi quella civile.
A tale conclusione non osterebbe – secondo il rimettente – la sentenza n. 186 del 2001, nella quale la Corte costituzionale avrebbe sottolineato come la lamentata diversità di trattamento troverebbe giustificazione nella peculiare posizione del cittadino inserito nell’ordinamento militare, poiché in quella occasione – sempre nella lettura della Corte militare d’appello – tale affermazione avrebbe riguardato una diversa ipotesi, ossia l’impossibilità di subordinare ad un interesse privato il perseguimento di reati in cui è insita un’offesa alla disciplina e al servizio (ciò, in particolare, si desumerebbe dalle precisazioni contenute nella successiva sentenza della Corte costituzionale n. 273 del 2009).
In ogni caso, sottolineano le ordinanze di rimessione, mentre la questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza n. 186 del 2001 aveva ad oggetto due differenti modalità di promovimento dell’azione penale, quella ora all’esame della Corte costituzionale pone a raffronto due fattispecie, punite l’una con la sanzione penale e l’altra con quella civile.
È, inoltre, ancora menzionata la sentenza n. 273 del 2009, nella quale la Corte costituzionale avrebbe affermato che la diffamazione militare (punita all’art. 227 cod. pen. mil. pace) e quella comune (di cui all’art. 595 cod. pen.) si distinguono esclusivamente per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa, che, per l’integrazione della prima fattispecie, devono essere entrambi militari. Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi – secondo il giudice a quo – per il reato di ingiuria.
Ad avviso del rimettente un diverso esito risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che avrebbe escluso che le esigenze della struttura militare possano essere considerate superiori agli altri beni costituzionalmente e ordinariamente tutelati (sono citate le sentenze n. 445 del 2002, n. 332 del 2000, n. 449 del 1999, n. 78 del 1989 e n. 278 del 1987).
Da ultimo, la Corte militare d’appello sottolinea come la formulazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace non consenta di individuare una connotazione di «militarità» della condotta che non sia la mera qualità di militari dei soggetti coinvolti: nessun altro elemento, cioè, consentirebbe al giudice militare di distinguere, nell’ambito della generale previsione contenuta nell’art. 226 cod. pen. mil. pace, un’ingiuria attinente a interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militare, o in generale ad interessi militari, rispetto ad un’ingiuria che tale connotazione non abbia. D’altro canto, sarebbe la previsione stessa dell’art. 199 cod. pen. mil. pace, in tema di non attinenza al servizio e alla disciplina militare, ad implicare l’impossibilità di connotare il reato previsto dall’art. 226 cod. pen. mil. pace come reato esclusivamente militare.
Pur dovendosi riconoscere, aggiunge il rimettente, che almeno per una parte delle condotte sussumibili nella previsione di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace sia ravvisabile «una, anche lata, correlazione con gli interessi, l’attività e l’ordinato andamento delle Forze Armate», che può giustificare la scelta del legislatore di mantenere una tutela di carattere penale, il vizio di legittimità costituzionale lamentato sarebbe, invece, palese per le ipotesi in cui nessun profilo di differenziazione con la norma penale comune sia riscontrabile e, dunque, «limitatamente alle fattispecie non connotate da alcun interesse militare».
3.– Con atti di identico tenore, rispettivamente depositati il 31 maggio 2016, il 14 giugno 2016 e il 5 luglio 2016, è intervenuto in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
Eccepisce preliminarmente la difesa statale, in relazione a tutti i giudizi, l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza dovuta alla carente descrizione della fattispecie concreta, essendo solo genericamente richiamate, nel corpo del provvedimento, alcune delle modalità del fatto contestato.
Quanto al merito delle censure, l’Avvocatura generale dello Stato osserva, anzitutto, che la selezione dei reati da «depenalizzare» costituisce una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore, sottratta al sindacato della Corte costituzionale, salvo il limite della ragionevolezza.
Nei casi sottoposti al giudizio della Corte costituzionale, non vi sarebbe comunque – ad avviso della difesa statale – alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati.
Dopo aver ricostruito il contenuto degli artt. 196, 199 e 226 cod. pen. mil. pace e il rapporto tra tali disposizioni, l’Avvocatura generale dello Stato si sofferma, in particolare, sul significato del reato previsto dall’art. 196 cod. pen. mil. pace (minaccia o ingiuria a un inferiore). Essa afferma che, senza dubbio, è tale previsione a rispondere all’esigenza di tutelare l’irrinunciabile bene della disciplina militare, strettamente connaturata al rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra il soggetto appartenente ad un grado superiore e quello appartenente ad un grado inferiore (il quale implica l’osservanza, da parte del primo, dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione). Ma segnala come sia, tuttavia, possibile, «in sintonia con gli orientamenti della Consulta», enucleare «un concetto di disciplina militare più ampio, inclusivo certamente dell’aspetto gerarchico, ma sussistente anche in assenza di esso». Sarebbe proprio la disposizione censurata, l’art. 226 cod. pen. mil. pace, a completare, dunque, la tutela della disciplina militare, intesa quale coesa e ordinata convivenza nell’ambito del consorzio militare. La stessa Corte costituzionale avrebbe, del resto, individuato quali interessi connaturati al concetto di disciplina quelli di efficienza e coesione delle Forze armate (è citata la sentenza n. 298 del 1995).
Non sarebbe pertanto irragionevole la scelta del legislatore di mantenere una più intensa risposta punitiva per un identico fatto materiale che risulti commesso – sebbene per ragioni estranee al servizio – in un contesto, quello militare, ove l’ordinata convivenza è posta a fondamento dell’efficienza stessa delle Forze armate.
Osserva, quindi, l’Avvocatura generale dello Stato che – diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze di rimessione – non vi sarebbe alcuna «regressione della garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari di fronte alle esigenze della struttura militare», in quanto l’ordinamento militare non si presenta «come un aliud o contrario», bensì come un regime basato su deroghe puntuali rispetto al modello dell’amministrazione civile. La diversità di trattamento tra militari e altri cittadini non fonderebbe le proprie ragioni sulla tutela di beni superiori, ma di beni diversi.
Il differente regime sanzionatorio lamentato dal rimettente nelle ordinanze di rimessione troverebbe, dunque, la propria ragione d’essere nel fatto che l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016 e l’art. 226 cod. pen. mil. pace apprestano la loro tutela ad interessi solo apparentemente uguali.
4.– Nel giudizio relativo all’ordinanza di rimessione n. 91 del 2016, si è costituito innanzi alla Corte costituzionale, con atto depositato il 30 maggio 2016, F. P., parte del giudizio a quo, chiedendo che siano accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte militare d’appello e che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace.
Considerato in diritto
1.– Con tre ordinanze di analogo tenore la Corte militare d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze armate dello Stato.
È osservato nelle ordinanze di rimessione che tali condotte, se poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto del disposto di cui all’art. 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).
Tale decreto ha, infatti, abrogato il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 del codice penale e ha previsto che il medesimo fatto, se commesso dolosamente, costituisce un illecito civile e che il responsabile è condannato, oltre alle restituzioni e al risarcimento del danno, al pagamento di una sanzione pecuniaria civile.
Ad avviso del rimettente, l’abrogazione dell’art. 594 cod. pen. avrebbe determinato un’irragionevole dilatazione del reato militare di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, in quanto tale disposizione consente di punire penalmente anche fatti che – pur commessi da militari nei confronti di altri militari – si rivelano estranei alla tutela degli interessi riconducibili al servizio o alla disciplina militari. Ciò produrrebbe un’ingiustificata diversità di trattamento tra militari imputati di ingiuria e soggetti non appartenenti alle Forze armate, in quanto ai primi si applicherebbe ancora la sanzione penale, mentre ai secondi quella civile.
Oltre al contrasto con l’art. 3 Cost., è lamentata la lesione dell’art. 52 Cost., in quanto, punendo con la sanzione militare anche condotte tenute in un contesto personale e privato, le esigenze della struttura militare finirebbero per porsi in una posizione di superiorità rispetto ad altri beni costituzionalmente ed ordinariamente tutelati.
2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con riferimento agli stessi parametri, sotto gli stessi profili e con le stesse argomentazioni. Ponendo, pertanto, identiche questioni, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia.
3.– In tutti i giudizi l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, assumendo che le ordinanze di rimessione non avrebbero adeguatamente illustrato le fattispecie sottoposte a giudizio. Ciò determinerebbe un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, preclusivo dell’esame del merito.
Tale eccezione deve essere respinta.
Va, in primo luogo, considerato che i giudici di primo grado hanno già qualificato in sentenza i fatti come astrattamente riconducibili al reato militare di ingiuria previsto dall’art. 226 cod. pen. mil. pace e che i rimettenti – in qualità di giudici d’appello – espressamente affermano di condividere tale qualificazione.
Quanto alla circostanza che le affermazioni asseritamente ingiuriose risultino non collegate al servizio e alla disciplina militare, per il momento e il luogo in cui sono pronunciate, essa emerge (per i giudizi di cui alle ordinanze r.o. nn. 102 e 117 del 2016) da una (pur essenziale) descrizione dei fatti di causa, ricavabile da entrambi i provvedimenti ricordati.
Vero che parca di informazioni sulla fattispecie di cui è giudizio risulta l’ordinanza r.o. n. 91 del 2016. Ma dalla motivazione di quest’ultima si evince che la vicenda all’esame del giudice d’appello attiene a più episodi di ingiuria militare, contestati nella forma del reato continuato, e che i giudici di prime cure hanno ritenuto di inquadrarla nella fattispecie di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, giacché, pur essendo l’imputato e la persona offesa militari rivestiti di grado diverso, la palese assenza di motivi attinenti al servizio e alla disciplina impediva di ipotizzare la distinta fattispecie di “ingiuria ad inferiore” ex art. 196 cod. pen. mil. pace. La circostanza che la stessa Corte d’appello affermi di condividere tale valutazione chiarisce come, anche nel giudizio di quest’ultima, le frasi offensive non presentino alcun collegamento con il servizio e la disciplina militare, così confermandosi l’applicabilità dell’art. 226 cod. pen. mil. pace e la rilevanza delle questioni sollevate.
4.– Reato «contro la persona» (così il Capo III del Titolo IV del codice penale militare di pace, nel quale è collocato), l’art. 226 punisce con la reclusione militare (fino a quattro mesi, ovvero fino a sei mesi se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato) il militare che offende l’onore o il decoro di altro militare presente, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, in particolare (per quel che rileva nelle fattispecie dei giudizi a quibus) il reato di ingiuria a un inferiore (art. 196 cod. pen. mil. pace).
Per comune consenso, consolidato attraverso la costante giurisprudenza di legittimità, l’area di applicazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace riguarda, anzitutto, i casi nei quali l’ingiuria, scambiata tra militari di grado diverso, avvenga per cause e in circostanze estranee al servizio e alla disciplina militare, come definite dall’art. 199 cod. pen. mil. pace. Il limite negativo di applicazione delle fattispecie dei più gravi reati di insubordinazione con ingiuria (art. 189 cod. pen. mil. pace) e di ingiuria a un inferiore (art. 196 cod. pen. mil. pace) si ricava appunto dall’art. 199 cod. pen. mil. pace (nel testo novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1985, n. 689, recante «Modifiche al codice penale militare di pace», quale risulta anche a seguito del parziale intervento ablativo di questa Corte, operato con sentenza n. 22 del 1991), il quale stabilisce (per la parte qui rilevante) che le norme relative (tra gli altri) ai reati di insubordinazione con ingiuria e di ingiuria ad un inferiore non si applicano quando alcuno dei fatti da esse previsti è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare e di un aeromobile militare.
In sostanza, i fatti di ingiuria commessi tra militari di grado diverso non integrano i reati di cui agli artt. 189 e 196 cod. pen. mil. pace allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare, ponendosi con questi in un rapporto di mera occasionalità. E, appunto, tali fatti, non essendo qualificabili come offensivi dello specifico interesse della disciplina militare, sono invece riconducibili al meno grave reato di ingiuria di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, che è (innanzitutto) reato contro la persona.
L’art. 226 cod. pen. mil. pace copre anche, ovviamente, i fatti d’ingiuria commessi tra militari di pari grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare, ma – si osservi – è altresì applicabile a quelli, sempre commessi tra militari di pari grado, che del bene della disciplina militare risultino invece offensivi, perché collegati a cause non estranee al servizio e alla disciplina come indicate all’art. 199 cod. pen. mil. pace. Il che induce a sottolineare che il reato di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace, reato innanzitutto contro la persona, non è estraneo all’area degli interessi ricollegabili al bene della disciplina militare.
5.– Ciò premesso, le questioni non sono fondate, con riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati.
5.1.– Le ordinanze di rimessione, come si è detto, non chiedono la caducazione dell’intero art. 226 cod. pen. mil. pace. Sul presupposto, appena chiarito, che la disposizione censurata punisce l’ingiuria tra militari di grado diverso se non c’è attinenza tra fatti ingiuriosi e disciplina e servizio militare, esse domandano, invece, una pronuncia che ne dichiari l’illegittimità costituzionale nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare, o comunque non afferenti ad interessi delle Forze armate. E non ci si può esimere dal rilevare, incidentalmente, che la manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momento, giacché obbligherebbe questa Corte a circoscrivere l’area di applicazione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace attraverso formule uguali o analoghe a quella contenuta nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, così scegliendo, tra quelle in astratto ipotizzabili, una delle molte soluzioni – nella disponibilità del legislatore – per selezionare interessi non più meritevoli di tutela penale.
In ogni caso, sottolineano i rimettenti che le condotte ingiuriose tuttora penalmente rilevanti per i militari, se poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, per effetto dell’abrogazione dell’art. 594 cod. pen. (art. 1, lettera c, del d.lgs. n. 7 del 2016) e della sua sostituzione, con efficacia anche retroattiva (art. 12 del citato d.lgs.), con il nuovo istituto della sanzione pecuniaria civile, esplicitamente applicabile anche a colui che offende l’onore o il decoro di una persona presente (art. 4 del medesimo d.lgs.).
La lesione all’art. 3 Cost., secondo le ordinanze di rimessione, consisterebbe perciò nell’irragionevole disparità di trattamento derivante dalla mancata estensione all’art. 226 cod. pen. mil. pace (nella parte appena precisata) della medesima sorte cui il legislatore ha scelto di sottoporre il “parallelo” reato di ingiuria di cui all’art. 594 cod. pen.
Quella all’art. 52 Cost. (considerando la giurisprudenza di questa Corte richiamata, si intuisce trattarsi del terzo comma di tale articolo, pur non esplicitamente citato né nelle motivazioni né nei dispositivi delle ordinanze) sarebbe dovuta alla prevalenza delle esigenze dell’ordinamento militare (che dovrebbe essere informato allo spirito democratico della Repubblica) insita in una previsione che stabilisce l’irrogazione della pena della reclusione militare anche a fronte di condotte tenute in contesti che con l’area degli interessi militari paiono privi di connessioni.
5.2.– Invero, e innanzitutto, la mancata ricomprensione dell’art. 226 cod. pen. mil. pace nell’ambito della abrogazione di reati che ha coinvolto l’art. 594 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 rientra sicuramente tra le scelte che il legislatore può compiere discrezionalmente, incontrando il limite della manifesta irragionevolezza.
Questa Corte ha stabilito che spetta al Parlamento una funzione centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare (ex multis, sentenze n. 127 del 2017, n. 5 del 2014, n. 364 del 2004; ordinanza n. 212 del 2004). Un tale principio risulta, a maggior ragione, applicabile anche al caso ora in esame, nel quale, in realtà, la scelta di politica criminale compiuta non ha determinato la trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, ma – per la prima volta, e con innovazione ben più radicale – ha trasferito determinate condotte dal campo del diritto penale, e delle relative sanzioni, a quello del diritto civile, attraverso la previsione di illeciti, i quali, se commessi con dolo, obbligano l’autore, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile, i cui proventi sono destinati al bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 7 del 2016.
5.3.– È vero, come osservano i rimettenti, che a seguito della trasformazione dell’ingiuria “comune” da illecito penale a illecito civile, l’ingiuria “militare” ex art. 226 cod. pen. mil. pace è divenuto reato esclusivamente militare, ai sensi dell’art. 37 cod. pen. mil. pace. Non può essere, tuttavia, considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell’area del penalmente rilevante l’ingiuria tra militari, quand’anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina e il servizio militare, come definito dall’art. 199 cod. pen. mil. pace. Ciò sia perché, in termini generali, ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze (ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000), sia soprattutto perché, con riferimento particolare alla censura sollevata dai rimettenti, non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all’onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, continuando così ad assistere con sanzioni penali le eventuali infrazioni a tali regole.
È vero che le fattispecie di reato di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace e all’abrogato art. 594 cod. pen. si distinguono solo per la qualità del soggetto attivo e della persona offesa (oltre che per tipologia ed entità della sanzione), tuttavia – a differenza di altre fattispecie oggetto di scrutinio da parte di questa Corte (sentenze n. 286 del 2008, n. 272 del 1997, n. 448 del 1991, n. 4 del 1974) – è proprio la qualifica militare di entrambi i soggetti (colui che offende e colui che subisce l’offesa) a rilevare per l’individuazione dei beni giuridici protetti dall’art. 226 cod. pen. mil. pace. Continuare a punire penalmente l’ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse.
Peraltro, come mostrano anche le fattispecie per cui è giudizio nei processi a quibus, la civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata coesione delle Forze armate. Considerazioni di fatto, ma non del tutto indifferenti ai fini dell’esito di questo giudizio di legittimità costituzionale, costringono inoltre a rilevare sia il permanere di episodi di “nonnismo”, pur dopo l’eliminazione della leva obbligatoria, sia l’insorgenza di ingiurie di natura sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare.
Proprio da questo punto di vista, è importante osservare come i reati per i quali è stabilita la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi – fra i quali l’ingiuria di cui all’art. 226 cod. pen. mil. pace – sono puniti non a querela, bensì su richiesta del comandante di corpo, sulla base di quanto disposto dall’art. 260 dello stesso codice.
La ratio di tale disposizione, ha più volte osservato questa Corte, risiede nella opportunità di attribuire al comandante di corpo una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare e il ricorso all’ordinaria azione penale, sul presupposto che vi siano casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l’esercizio incondizionato dell’azione penale può causare al decoro dell’istituzione militare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato stesso (sentenze n. 449 del 1991, n. 114 del 1982, n. 189 del 1976, n. 42 del 1975; ordinanze n. 186 del 2001, n. 562 e n. 410 del 2000, n. 396 del 1996).
Si deve, ora, aggiungere che l’eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, determinando l’assorbimento delle vicende ingiuriose nella sfera civilistica e “privata” dei contendenti, avrebbe tra i suoi non trascurabili effetti anche quello di impedire al comandante di corpo di chiedere il procedimento penale, a tutela di una vittima (dell’ingiuria) inserita in un contesto caratterizzato da rapporti di natura gerarchica. Un accoglimento, si osservi, che potrebbe persino provocare l’effetto di privare il suddetto comandante dell’opportunità di avere contezza dei fatti accaduti, presupposto per avviare almeno la (in quell’ipotesi residua) azione disciplinare.
5.4.– Quanto alla censura relativa all’asserita violazione dell’art. 52 Cost. (e in particolare del suo terzo comma, come s’è detto), è sufficiente osservare che il mantenimento dell’ingiuria tra militari nell’area del penalmente rilevante, pur quando commessa per cause estranee al servizio o alla disciplina militare, trova ragionevole fondamento nelle, appena ricordate, basilari esigenze di coesione dei corpi militari. Sotto questo profilo, tale soluzione non trasmoda in un contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l’ordinamento delle Forze armate (sentenza n. 45 del 1992 e ordinanza n. 322 del 2013).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, dalla Corte militare d’appello di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE